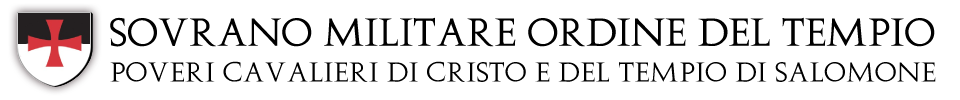(Guia Soncini di Linkiesta) – Ogni mattina un relitto del Novecento si sveglia, apre i giornali e, prima ancora che il caffè sia pronto, già ha ringraziato sette o otto volte d’esser stato vivo in un altro secolo.
Un secolo in cui le rockstar si strafacevano, mica smentivano maiuscolando che come vi viene in mente di pensarci a pippare coca, noi siamo CONTRARI alla droga.
Siamo nell’epoca in cui le rockstar si vestono trasgressive, vanno sul palco a cantare che sono fuori di testa, e poi, quando una foto ambigua fa spargere la voce che tirassero di coca durante la gara di canzoni, maiuscolano che come ci si permette di ritenerli gentaglia che si droga, fuori di testa sì ma solo grazie alla tisana alla malva. Vedi mai che qualcuno si senta offeso se pippano. Idea per un soggetto comico: Keith Richards si preoccupa della propria reputazione.
La mia memoria è evidentemente lasca, e non ho neanche la giustificazione di Rushdie, che magari ha rimosso come andò negli anni Ottanta perché la fatwa rese la sua vita un inferno e la rimozione è un meccanismo sano. Certo, ci furono intellettuali che solidarizzarono. Ma ci furono anche: John Le Carré che scrisse che doveva ritirare il libro giacché nessuno ha il diritto d’insultare una religione e restare impunito; il principe Carlo che, a una festa, disse qualcosa di simile a Martin Amis; Germaine Greer che gli dava del megalomane; Roald Dahl che gli diede del «pericoloso opportunista», ipotizzando avesse fatto apposta a provocare gli islamici per ottenerne pubblicità e un bestseller (vi fareste mettere una taglia sulla testa per andare in classifica?).
Quindi non siamo meno tolleranti del solito: si nota solo di più.
Persino quelli che dovrebbero essere più lucidi, che sanno che la libertà d’espressione o è estremista o non è, che serve a tutelare le opinioni che ti fanno schifo e non quelle che ti piacciono, persino noialtri poi abbiamo le nostre zone cieche di suscettibilità.
La giornalista licenziata dall’Associated Press per aver fatto dei post su Facebook in cui raccontava la propria militanza a favore dei palestinesi sarebbe stata più difesa se quella militanza fosse stata a favore di Israele? Probabilmente sì, giacché non esistono cause impresentabili in assoluto, ma solo cause impresentabili agli occhi d’una parte dell’opinione pubblica, e quella parte dell’opinione pubblica che si è incaricata di dire che non va bene licenziare qualcuno per le sue opinioni è anche quella parte per la quale è però inaccettabile che la tua opinione sia contraria a Israele.
Ma è troppo facile difendere i nostri sodali, quelli che la pensano come noi, i frammenti del nostro specchio. Non è una battaglia culturale, così: è un riflesso pavloviano. È difendendo i cattivi (che sono quasi sempre relativi: siamo tutti i cattivi di qualcuno che la pensa diversamente) che ci si dimostra i buoni.
Difendendo persino la libertà del tizio che andò sotto al Raphaël a tirare le monetine di diventare, decenni dopo, docente universitario; mica facendo – dico a lei, senatore Renzi, che dev’essere impazzito – un’interrogazione parlamentare per togliergli la cattedra perché è uno dei cattivi. Con lo stesso pavlovismo per cui si tiravano le monetine, peraltro: ventott’anni fa il cattivo era Craxi; su questa cosa che non è che contro i cattivi sia consentito tutto sarebbe meglio non cambiare idea ogni quarto d’ora, e non solo perché, vista la rapida mutazione della pubblica suscettibilità, uno di questi giorni i cattivi potremmo essere noi.
È se pensi che la religione sia una cosa importante che conta la tua difesa di Rushdie. Se, come me, pensi che qualunque credente di qualunque religione sia imbecille, non vale poi molto il tuo ritenere ovvio il suo diritto a scrivere un romanzo. Christopher Hitchens, il migliore degli atei, disse che il suo amico Salman aveva “ricevuto una condanna a morte e una a vita, per il crimine d’aver scritto un’opera di fantasia”: sarebbe bello che quella stessa frase l’avesse detta un credente.
Ma, se non succedeva nell’illuminato Novecento, figuriamoci in questo suscettibile secolo.
Il New York Times ha intervistato Corinne Rey, la vignettista che aprì la porta ai terroristi che fecero una strage nella redazione di Charlie Hebdo. Rey, in arte Coco, ha pubblicato un romanzo a fumetti sul suo senso di colpa.
Nel 2015 PEN, associazione americana dedita da novantanove anni a difendere la libertà d’espressione, dedicò la propria annuale serata di gala ai disegnatori di Charlie Hebdo che quell’anno erano stati uccisi. Sei scrittori – piuttosto noti, da Rachel Kushner a Teju Cole – per protesta si dimisero dall’associazione. Rushdie si incazzò moltissimo, chiedendosi a cosa servisse essere letterati in difesa della libertà d’espressione se si avevano dei dubbi nello stare dalla parte di gente ammazzata per aver fatto delle vignette. «Senzapalle. Sei autori in cerca d’un briciolo di carattere», twittò. O almeno così dice il Guardian: non posso controllare perché Rushdie mi ha bloccata su Twitter da anni. Ci penso ogni volta che qualche inattrezzato scrive «cosa parla di suscettibilità, la Soncini, che mi ha bloccato su Twitter»: sono molto certa che il diritto altrui di esprimersi non corrisponda a un dovere mio di ascoltarlo, e che Rushdie non abbia leso la mia libertà d’espressione; e sono altrettanto certa che Rushdie abbia bloccato me per la stessa ragione per cui io blocco decine di persone al giorno: non pensando “santo cielo, che temibile dialettica”, ma pensando “ommadonna che noia”.
Se hanno dubbi gli scrittori nel difendere un assoluto quale pare essere «non c’è vignetta che valga la pena di morte», figuriamoci se ci si può aspettare che i cantanti drogati vengano difesi dallo spettatore medio, o i princîpi astratti dalle scuole spaventate: una scuola francese ha rifiutato d’essere intitolata all’insegnante decapitato in autunno dai terroristi islamici, per paura di diventare a sua volta bersaglio terroristico.
Non ce lo possiamo aspettare in questo secolo, ma forse non era così automatico neanche in quello scorso. All’editore americano di Rushdie rifiutarono di vendere un appartamento a New York. All’assemblea di condominio, un inquilino del palazzo obiettò: e se arrivano e sbagliano porta e ammazzano me? L’editore commentava sconsolato che non è che la sua, di porta, sarebbe evidentemente stata quella alla quale era giusto ammazzare qualcuno.
L’osservatrice di beghe in sessantaquattresimo, quella che di solito non vede la libertà – d’essere maleducati o drogati o ironici o chissà che altra violazione del sentire comune – pagata con ammazzamenti, ma al massimo con cancelletti, si chiede per un attimo se il guaio non sia proprio quello: che siamo altrettanto vili, ma senza rischiare la vita.