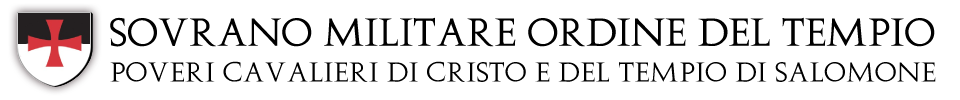Milano (Ernesto Galli della Loggia del Corriere della Sera) – Tra le giustificazioni ascoltate in queste ore per cercare di non vergognarci della nostra condotta in Afghanistan, insieme stupida e vile, una merita l’oscar dell’ipocrisia. È quella secondo la quale sarebbe sciocco oltre che inutile tentare di «esportare la democrazia» in culture diverse dalla nostra. (Un discorso completamente diverso, anche se spesso furbescamente confuso con questo e quindi da tenere separato, è quello sui modi, giusti o sbagliati, con i quali lo si può fare).
Su che cosa si debba intendere per democrazia si può discutere anni. Diciamo, tenendoci proprio ai minimi termini, che per democrazia intendiamo un governo che in qualche modo risponda ai governati e che riconosca e garantisca agli stessi, sia uomini che donne, un certo numero di diritti basilari di libertà (chiamiamoli pure diritti umani). Bene: oggi molti si affrettano a sostenere che un regime siffatto — che trae origine da un’evoluzione storica propria della cultura dell’Occidente — sia adatto per ciò solo alle popolazioni che condividono tale cultura, e che quindi esso non possa essere in alcun modo trapiantato dove tale cultura non ha mai allignato.
Tuttavia questa affermazione perentoria solleva inevitabilmente una domanda: chi lo decide che le cose stanno davvero così? Chi decide circa la validità di questa sorta di legge bronzea dell’incompatibilità culturale? Il Congresso Mondiale degli Antropologi e degli Storici Riuniti? Chi? Sembrerebbe abbastanza ovvio che forse dovrebbero deciderlo gli interessati, cioè gli stessi appartenenti alla cultura «altra» rispetto alla nostra. Che dovrebbero essere loro a dire: “No grazie, la libertà di parola non c’interessa, e della garanzia di non essere prelevati nottetempo dalla polizia e magari fucilati senza processo facciamo volentieri a meno”.
Peccato che invece a invocare l’argomento della incompatibilità culturale rispetto alla democrazia siano regolarmente non già gli eventuali diretti interessati ma solo e sempre coloro che sono arrivati a governarli, sebbene non abbiano ricevuto quasi mai, guarda caso, alcuna effettiva e credibile investitura. Ad arrogarsi il diritto di proclamare la legge bronzea dell’incompatibilità culturale, infatti, sono sempre e soltanto «le autorità», le élite civili, militari, culturali o religiose, cioè quelli che in qualche modo comandano e dirigono e che come è ovvio hanno tutto l’interesse a continuare a farlo indisturbati. Naturalmente guardandosi bene dal chiedere l’opinione dei diretti interessati. È una vecchia storia che peraltro riguarda anche noi. Non è forse vero che anche qui in Europa al loro tempo i governanti fascisti e comunisti sostenevano che la marcia e corrotta democrazia liberale non era adatta ai loro rispettivi popoli, alla loro cultura, alle loro aspirazioni?
In queste ore, dunque, una fitta schiera di occidentali molto sapienti e avveduti o di politici furbastri di tutti i colori ci ripetono quale sciocchezza sia stata la spedizione in Afghanistan, che pure ha avuto l’innegabile conseguenza di dare per qualche anno un po’di eguaglianza e di libertà a un certo numero di donne e di uomini di quel Paese. Mi chiedo però perché mai a nessuno degli acuti osservatori di cui sopra venga in mente che forse bisognerebbe chiedere anche a quelle donne e a quegli uomini se l’idea di andare a Kabul a «esportare la democrazia» fosse davvero così assurda e da scartare? La loro opinione è proprio così irrilevante?
La verità è che c’è un solo argomento forte a favore dei sostenitori dell’incompatibilità culturale: la Storia. Ognuno se ne stia a casa sua, rassegnato e contento di ciò che il passato ha deciso per lui: quale cultura seguire, sotto quale legge, o religione o regime politico vivere. E dunque se in quel posto alle fanciulle si pratica da sempre l’infibulazione, o se da un’altra parte la sorte riservata agli omosessuali è l’impiccagione, o se da un’altra parte ancora si fanno marcire in galera gli oppositori politici, ma se tutto ciò avviene in omaggio a qualche tradizione, a qualche cultura o religione più o meno liberamente interpretata o manipolata, chi siamo noi occidentali per arrogarci il diritto di intervenire, di far valere i nostri princìpi sfidando il Passato e il Moloch della Storia?
Ma davvero è questo ciò che pensano oggi i democratici italiani? E se realmente essi credono che non si debba né si possa esportare la democrazia, che solo noi possiamo godere di certi diritti, perché mai allora da anni si ostinano a chiedere ad esempio che l’Egitto rinunci alla sua «cultura» e si decida a far processare come si deve gli assassini di Giulio Regeni o a liberare il povero Patrik Zaki? Forse, immagino, perché pensano che in questo caso non si tratti per nulla della cultura degli egiziani ma semplicemente degli sporchi interessi del loro governo. Ma se è così, allora in chissà quanti altri Paesi del mondo capita la stessa cosa, e cioè che chi è senza potere, la gente comune, vorrebbe un po’ di habeas corpus e di diritti civili ma chi detiene il potere ha deciso altrimenti: e naturalmente lo fa sempre in nome della Cultura, della Storia, della Religione. Chissà in quanti altri Paesi: forse anche in Afghanistan…
Ancora: perché mai i democratici di casa nostra, se davvero pensano che dobbiamo lasciare indisturbati i Paesi con una storia diversa da quella occidentale, non perdono però occasione di invocare continuamente le Nazioni Unite, le quali con tutta la sfilza delle loro carte e dichiarazioni sulle libertà e i diritti sono senza dubbio la più grande organizzazione mondiale per l’esportazione ideologica della democrazia? Perché?
E tuttavia, si dice, è questione anche di modi: si può mai esportare la democrazia con la guerra? Può avere dei dubbi nel rispondere solo chi dimentica che da un paio di secoli proprio questo è successo innumerevoli volte. C’è una sola cosa sulla quale invece non si possono avere dubbi: ed è che se si fa una guerra del genere allora bisogna assolutamente vincerla, costi quel che costi. Ma questo, come si capisce, è un altro discorso.