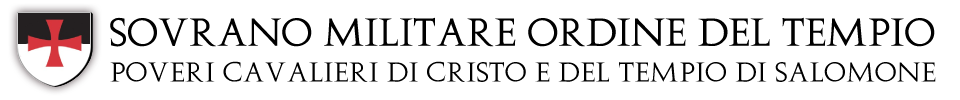(Piero Fassino da Huff Post) – Ringrazio Mattia Feltri di aver voluto promuovere su HuffPost una riflessione su un tema – “Si esporta la democrazia?” – che si ripropone ogni volta che una missione internazionale messa in campo dall’Occidente per promuovere diritti conosce un esito infausto, come accade in Afghanistan. E l’istintiva risposta è in genere negativa. Eppure il fatto che tutto il mondo democratico oggi invochi angosciato la difesa degli spazi di libertà e dei diritti garantiti in questi vent’anni alle donne afghane dice che la risposta a quell’interrogativo deve essere meno epidermica e banale.
Chi sostiene l’inutilità o l’erroneità di proporre soluzioni democratiche a Paesi che non hanno tradizioni democratiche invoca l’irriducibilità delle diversità identitarie. Certo, nel pianeta convivono una pluralità di religioni, civiltà, culture, etnie che esprimono una pluralità di lingue, alfabeti, stili di vita, regole morali, pratiche religiose, norme e consuetudini. Omologare tutto ciò a un pensiero unico sarebbe errato e velleitario. Di più, impossibile. Ma – qui è uno dei nodi da sciogliere – il riconoscimento e il rispetto delle identità giustifica la negazione di diritti umani e civili fondamentali? Quei diritti che la giurisprudenza definisce “indisponibili” nel senso che non ne possono disporre altri se non la persona medesima. Essere curato, studiare, amare, vivere la propria sessualità, pregare il proprio Dio, manifestare le proprie opinioni, sono diritti “naturali” che appartengono a ogni donna e ogni uomo quale che sia il colore della pelle, il luogo di nascita il sesso e il genere, la lingua, l’etnia, il dio che prega.
Si dirà: ma in Afghanistan vietare alle bambine di andare a scuola è espressione della loro religione. No, quel divieto deriva da un’interpretazione estrema e integralista smentita dal diritto all’istruzione assicurato in gran parte dei Paesi a religione musulmana, dal Marocco al Pakistan, dall’Algeria all’Indonesia, dall’Egitto all’Iran, dalla Tunisia alla Malesia. Insomma: liberiamoci dal relativismo culturale di invocare le diversità identitarie per giustificare negazioni di diritti che giustificabili non sono. Le diversità vanno riconosciute e rispettate, ma non possono giustificare la negazione di diritti umani e civili fondamentali.
Una seconda questione è quali debbano essere gli strumenti con cui affermare i diritti là dove sono negati o repressi. Fino ad oggi la comunità internazionale si e’ affidata a tre strumenti. La moral suasion che tuttavia ha efficacia in quanto il destinatario sia disponibile a farsi persuadere. Le sanzioni economiche che tuttavia sono adottate e applicate solo dall’occidente e peraltro con efficacia limitata in un’economia globale a mercati aperti. Al punto che nel medio periodo le sanzioni penalizzano più chi le impone che chi le subisce. E peraltro il peso enorme degli interessi economici induce renitenza e consente il doppio standard per cui con facilità si impongono sanzioni a paesi minori, ma con enorme difficoltà a Paesi maggiori, come ad esempio la Cina.
Di fronte a situazioni che rappresentano una minaccia alla sicurezza del mondo o di un continente o di una regione la comunità internazionale ricorre allo strumento militare in due diverse modalità: peacekeeping laddove occorre garantire il rispetto di accordi di pace, come nei Balcani e in Libano; peaceenforcing laddove bisogna combattere conflitti o attività terroristiche, come in Afghanistan o nel Sahel. Strumenti all’inizio sostenuti da consenso che tuttavia – soprattutto nel caso di peaceenforcing – il protrarsi nel tempo logora, per cui le opinioni pubbliche dei Paesi che inviano soldati si chiedono perché i loro figli debbano cadere per cause lontane e i Paesi destinatari dell’intervento lo rifiutano come lesivo della loro identità e sovranità e lo combattono. L’Afghanistan è l’esempio di questa dinamica.
Vuol dire questo che non si debba ricorre alle missioni militari? Non mi pare che sia questa la risposta. Senza l’intervento militare internazionale i santuari terroristi di Bin Laden e Al Qaeda non sarebbero stati stroncati. E senza la presenza internazionale la società afghana, le donne, i giovani non avrebbero goduto degli spazi di libertà e dei diritti che oggi vengono brutalmente negati dal ritorno al potere dei talebani. Se mai altra questione si pone: non considerare lo strumento militare esaustivo. La forza serve alla politica, ma non la sostituisce. Ed è questo forse il deficit più evidente di vent’anni di presenza occidentale in Afghanistan: la fragilità dell’azione civile e sociale. Una democrazia non può vivere solo sulle canne dei fucili. C’è contemporaneamente bisogno di un robusto, continuo e diffuso investimento nella costruzione di quella infrastruttura sociale, civile, economica che consente a un cittadino di constatare che con la democrazia si hanno più diritti, più opportunità di vita, più certezze.
È un tema a cui gli Stati Uniti sono meno attenti perché la società americana non ha una cultura del welfare, che invece è il tratto distintivo delle società europee. La vicenda afghana, insomma, dice che se la democrazia non si “esporta”, la si può e la si deve promuovere laddove oggi è negata. Ma questo impone che non la si affidi solo alle armi e ogni iniziativa di promozione della democrazia – sia dove vi sia dimensione militare, sia dove non vi si ricorra – preveda la messa in campo di una robusta ed efficace strategia di promozione civile, sociale, economica.